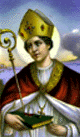VALENTINA MANILA
Aumentano gli interventi di autori sconosciuti giunti a me via email, come il seguente. E' una scrittura un po' arrabbiata quella di Valentina Manila, almeno a giudicare da questo curioso racconto che mischia liberamente elementi presi dalla nostra storia recente con la finzione narrativa. Un racconto paradossale e simbolico, incentrato sulla figura di un personaggio muto per vocazione e che abbraccia oltre dieci anni di piccole tragedie italiane. Senza contare che la scelta di creare una star televisiva immaginaria e farla vivere sul palco del Costanzo Show sono elementi che non potevano lasciare indifferente il cuore pop di 'tina.
Silenziatrice
Loro pagano il mio silenzio.
Perché chiunque di noi (anche tu, hypocrite lecteur! - mon semblable - mon frère) vive
di talenti che sa vendersi, e io vendo l'angoscia che ho dentro. Sono un artista del
mutismo, un autorità del taciuto, un profeta del non detto. Non c'è apostrofo fra un e
artista perché il fatto che io sia donna non c'entra. Non c'è apostrofo fra un e
autorità per lo stesso motivo. Uso il termine profeta e non profetessa perché profetessa
come parola fa schifo, e forse non esiste neanche.
Io comunque è di questo che mi occupo: dell'inesprimibilità dell'orrore.
C'è un origine in tutte le cose e la mia origine è una casualità.
Nel 1989 io ero ancora in università. Giurisprudenza, quarto anno. Tutte le mattine, o
quasi, aspettavo che la mia amica Mara passasse a chiamarmi per andare a lezione insieme.
Da casa dei miei all'istituto erano venti minuti a piedi, di passo comodo, come quello
chiacchierato di me e Mara. Ogni tanto ci fermavamo per un caffè prima di arrivare in
aula, oppure prendevamo il giornale e lo sfogliavamo nei chiostri per il piacere di tirare
tardi, di dover correre a lezione trafelate pur di goderci gli ultimi attimi di libertà
prima del mortorio di Diritto Privato o Procedura Civile.
Pavia alle nove è in balia degli studenti, come una corrente di energia giovanile
nell'aria che avresti voglia di assorbire e portarti dentro tutto il giorno. Biciclette
che filano, gruppi di ragazzi che prendono un cappuccino in piedi scalpitando, le code
rumorose e stravaccate fuori dalla segreteria. Quella mattina però non c'era tempo per le
solite soste, Mara era passata da me più tardi e ormai gli spazi perditempo erano tutti
scaduti. Passando in Piazza del Duomo Mara ha voluto comunque fermarsi all'edicola. - Dai
aspetta, ci metto un secondo -. Io fingevo una dedizione allo studio che non era la mia,
imponendole di tirare dritta, inutilmente. - Va beh, vai pure avanti, prendo La Provincia
e ti raggiungo -. Testarda, ho fatto finta di non sentirla e ho tirato dritta. Dieci,
venti, trenta passi, poi il boato. Un rumore di terremoto compresso che non si può
spiegare, di bomba implosa che senti più nel petto che nell'aria. Mi sono voltata come in
un film a rallentatore. Il chiosco dei giornali non c'era più. Una nuvola di polvere
germogliava dall'ammasso di mattoni e calcinacci. La torre del Duomo si era sfracellata
sulla piazza.
Alcuni pensieri sono difficili da formulare anche davanti all'evidenza. Persino se lo vedi
accadere, non riesci a concepire realmente che un campanile monumentale, la punta con cui
un Duomo tocca il cielo da secoli, un simbolo da cartolina e da libri di storia,
improvvisamente precipiti su se stesso travolgendo il mondo circostante. Ci sono cose che
passano e cose che restano. Noi passiamo, le chiese restano. Questo mi avevano insegnato.
Ma ora la realtà stava sbriciolando le mie convinzioni in un cumulo di macerie. E Mara
era là sotto, da qualche parte.
Intorno a me le urla, la gente impazzita che fuggiva, la gente impazzita che accorreva. Io
ero ferma come una diapositiva, troppo sconvolta per muovermi, per reagire. Finché una
signora coi capelli bianchi svolazzanti e un grembiule nel quale si asciugava nervosamente
le mani, venne a chiamarmi e mi invitò a sedere all'interno del suo bar. Le andai dietro
quasi senza capire. Lei mi fece accomodare a un tavolino e portò una tazza di tè caldo
di cui mi limitai a sentire l'aroma fumante. Qualche cliente mi venne vicino, chi per
domandare qualcosa, chi per toccarmi un spalla, chi per mormorare "poverina". La
signora, angelo custode, li allontanava con un gesto - Su, lasciatela in pace -. Io non
capivo nulla, non sentivo nulla. Pensavo solo a Mara. Nella mia testa c'era la sua voce,
il suo viso, il suo nome come un'eco gigante.
Non ricordo quanto tempo passò prima che mi rendessi conto della gente sulla porta. La
notizia della mia presenza nel bar si era sparsa e una folla di giornalisti cercava di
entrare per parlarmi. Ero una testimone e ancora non lo sapevo.
Lentamente mi alzai e andai verso di loro. L'angelo coi capelli bianchi, che a stento
cercava di tenerli fuori dal locale, quando vide che mi avvicinavo mi sorrise come una
madre e tornò dietro il suo bancone. Mi accostai alla porta. Mi assalirono.
- Signorina, come è successo?
- Cosa ha visto?
- Cosa ha sentito?
- Cosa ha provato?
- Era il suo fidanzato?
- Era una sua amica?
- Era suo padre?
- Signorina, dica qualcosa
Io fissavo granitica il serpeggiare dei microfoni, che si avvicinavano e ritraevano come
teste sibilanti, trafitta dagli occhi polifemici delle telecamere a spalla. E tacevo di un
silenzio interiore assordante.
Solo quando il nugolo di giornalisti ha cominciato a perdere le speranze di ottenere una
dichiarazione, allontanando i microfoni quasi contemporaneamente, come flebo da un malato
terminale e irreversibile, mi è uscita quell'unica frase che ha cambiato il mio destino.
Ho detto: - Questo silenzio è per Mara -.
Nient'altro. Ma è stato sufficiente.
Quella sera stessa non c'è stato telegiornale che non abbia trasmesso la mia immagine
muta, il mio sguardo fisso come simbolo della tragedia, le mie parole come omaggio estremo
per coloro che erano scomparsi. Il giorno dopo la mia foto era sulla prima pagina di
qualunque quotidiano, accanto all'immagine drammatica della torre accartocciata su stessa.
Io e la tragedia eravamo già una cosa sola. Testa e croce dello stesso evento.
Cominciarono a chiamarmi a casa. Dalle redazioni dei settimanali, dalle radio, dagli studi
televisivi. Erano assetati delle mie opinioni come cani al guinzaglio tenuti troppo a
lungo lontano da una fonte d'acqua. Mi cercavano, mi seguivano, mi pregavano. Che io
aprissi bocca per loro, che traducessi in discorso il mio dolore, che recitassi la parte
della Vittima davanti alla nazione intera.
Lasciavo che fossero i miei genitori a rispondere. Facevo di no con la testa a qualunque
richiesta, allontanavo le proposte con un gesto nervoso della mano.
Il mio negarmi per loro equivaleva solo ad alzare il tiro.
E lo alzarono.
Chiamò lo "Speciale TG1". Chiamò "Mixer". Chiamò Canale 5.
I miei genitori a sentire i nomi di Enzo Biagi, di Bruno Vespa, di Gianni Minà, facevano
tremare il ricevitore, mi guardavano increduli, come se improvvisamente mi fossi
trasformata in un essere alieno e irraggiungibile, del tutto differente dalla figlia che
avevano generato e conosciuto.
Mia madre mi porgeva l'apparecchio e mormorava: - Ma è il TG2... Non puoi NON parlarci. -
Io scappavo in camera mia, ma non serviva a nulla.
Chiamò anche il "Maurizio Costanzo Show". Una redattrice tanto solerte da
convincere mia madre a bussare per ben quattro volte alla mia porta.
Alla fine cedetti. Ma a modo mio.
La guardai negli occhi e dissi: - Ci vado, ma solo se mi fanno tacere -. La redattrice
dello show, che aveva sentito dal ricevitore ancor prima che mia madre riferisse, accettò
immediatamente: - Va benissimo, le dica che ci va bene -.
Io non lo sapevo ancora, ma in quel preciso istante avevo siglato un patto col mio destino
professionale.
All'aeroporto trovai ad attendermi una ragazza col mio nome su un cartello col logo
FININVEST. Mi accolse con grandi sorrisi e un'accondiscendenza sospetta. Dovevano averle
detto che ero una specie di pazza, che andavo trattata con cautela. Aveva all'incirca i
miei 25 anni. Mentre l'autista ci guidava verso il teatro avrei voluto parlare un po' con
lei, chiederle del suo lavoro, di come si viveva a Roma, di dove andare la sera. Invece la
ragazza sembrava non considerarmi come una sua coetanea. Mi dava del lei, era piena di
premure e soggezione, come se fossi una stella di qualche galassia cinematografica
lontana. Mi nutrii del suo imbarazzo e finii per restituirglielo amplificato. Giunti al
Parioli ormai guardavamo entrambe altrove, occhi estranei fuori da finestrini opposti.
Mi lasciai trascinare tra parrucchiere, truccatrici, costumiste. Il risultato finale fu
una strabiliante dimostrazione di illusionismo: artisti dell'invisibile che avevano
lavorato la mia immagine, lasciandola immutata, eppure impercettibilmente rivoluzionata
per esigenze di schermo. I miei capelli più luminosi dei miei capelli, la mia pelle più
compatta della mia pelle, i miei occhi più intensi dei miei occhi. Tutto uguale eppure
tutto indefinibilmente diverso.
Un assistente di scena venne a comunicarmi che Costanzo voleva conoscermi di persona prima
di andare in onda. Gli mandai a dire che sarebbe stato inutile, che ero venuta lì per
tacere e che avrei taciuto anche con lui. Che il mio silenzio necessitava concentrazione,
impegno. L'assistente disse che capiva, e se ne andò. Capiva? Cosa c'era da capire? Era
gente pagata per accettare imposizioni, e infatti le accettava. Da chiunque. Persino da
me.
Ci fecero attendere dietro le quinte. La ragazza dell'aeroporto era lì per dirci quando
entrare. Vicino a me c'erano gli altri ospiti della trasmissione: un comico, una velina,
uno scrittore americano con la solita traduttrice brunetta e due personaggi sconosciuti,
almeno per me. Il conduttore annunciava i nostri nomi e la tenda laterale del palco si
apriva per farci entrare in scena. Quando fui chiamata la ragazza al mio fianco disse: -
Tocca a te -. Per un attimo mi voltai e la osservai con sincero sbalordimento. Mi prendeva
per scema? Era il mio nome, ero l'ultima ospite rimasta, la tenda era accostata per il mio
passaggio. Era chiaro che toccasse a me. Scossi la testa ed entrai.
La televisione. L'applauso del pubblico in sala. I riflettori accesi. I volti
sorridenti. L'unica poltroncina rimasta vuota.
- Davvero non parlerà? - mi chiese il presentatore appena presi posto. Io non risposi
neppure. Puntavo gli occhi oltre la sala, in un punto perduto oltre gli spettatori.
Stavo improvvisando il mio silenzio, ed ero bravissima.
Lo show finì per svolgersi come se io non fossi stata presente. Domande, risposte,
risate, imbarazzi. Silenzi, nessuno. Il silenzio era prerogativa mia. Ogni tanto una
lucetta rossa denunciava una mia inquadratura furtiva, testimoniava la mia esistenza
catodica. Solo alla fine, pochi secondi prima che le tende si chiudessero e la
registrazione televisiva venisse conclusa, Costanzo tornò accanto a me.
- Questo silenzio è sempre per Mara? - chiese.
E lì, sorprendendo tutti, parlai. Dissi: - A Mara ho già offerto il mio silenzio. Questo
era per le altre vittime del crollo -.
Il teatro intero a quel punto era immobile. Un concerto di occhi puntati e bocche
semiaperte. Poi la tensione si spezzò, partì l'applauso, il conduttore mi sorrise
soddisfatto, gli ospiti a mio fianco non nascosero due lacrime a testa.
Titoli di coda in sovrimpressione.
Potevo andare a casa.
Me l'ero cavata, pensavo. La faccenda è chiusa per sempre, pensavo. Adesso posso stare
tranquilla, pensavo.
Il telefono non mi ha neppure dato il tempo di rientrare a Pavia. Meno di dodici ore dopo
la messa in onda il numero delle richieste era triplicato. E la redattrice dello show,
gentile portavoce del potere mediatico, aveva lasciato un messaggio categorico come una
condanna: ogni martedì sera, sino a fine anno. E una cifra grande come la liquidazione di
mio padre dopo trent'anni di onesto faticare in ditta metalmeccanica.
Guardavo le lacrime di commozione negli occhi dei miei genitori, le date circolate sul
calendario della cucina, il mio volto pixelato nella replica delle 10 e 30 mattutine.
Guardavo la mia vita prendere un'altra direzione.
Alla televisione ti abitui, come a un morbo grave una volta che sai di averlo
contratto. E proprio di contratto si tratta, anche qui. Fare l'ospite è diventata la mia
qualifica professionale, come per altri lo è medico, ballerina, astronauta. Così mi sono
applicata, ho fatto esperienze, sino alla specializzazione.
In oltre dieci anni di trasmissioni televisive ho taciuto per le vittime della Guerra del
Golfo, per gli alluvionati di Alessandria, per i profughi albanesi, per i caduti in
Bosnia, per i deportati del Kossovo, per i terremotati di Assisi, per Giovanni Falcone,
per Paolo Borsellino, per Lady Diana, per Madre Teresa, per le vittime del mostro di
Marcinelle, per Marta Russo, per John-John Kennedy e sua moglie Carolyn. La cronaca si
affrettava a produrre tragedie a cui dedicare il mio silenzio. Io aprivo i giornali,
leggevo i nomi, li ripetevo a telecamere accese. In bocca a me il lutto acquistava
dignità, la morte palesava un senso che prima nessuno pareva aver colto con altrettanta
intensità.
La mia fama si propagava come un virus. Ogni settimana ricevevo inviti per nuove
trasmissioni, interviste, servizi fotografici. Cominciavo a percepire come l'interesse
intorno alla mia persona attirasse non solo simpatie, ma anche sospetto e rabbia. Mi
accorgevo del tono di viscida compiacenza di persone sconosciute che improvvisamente mi
gravitavano attorno. Leggevo l'invidia negli occhi delle vallette, rabbiose all'idea che
avevo raggiunto la popolarità a cui tanto ferocemente loro aspiravano chiudendo quella
bocca che troppo spesso e controvoglia loro sono state costrette ad aprire coi dirigenti.
Queste vibrazioni negative e potenti mi allarmavano e allo stesso tempo confermavano la
mia posizione.
Il silenzio era potere, e il silenzio ormai era patrimonio esclusivamente mio.
Lo so che adesso a voi sembra facile.
Adesso che vi siete abituati al mio volto, al mio mutismo amplificato dai media, alla mia
taciuta presenza sugli schermi di casa vostra. Vi sembra tutto normale, assodato.
Che ci vuole? pensate. Sarei capace anch'io, pensate. Sono buoni tutti a farlo, pensate.
Ma il talento è vocazione, non intuizione. Ma la vocazione talvolta è un pesante
fardello.
Quando è morta mia madre, due mesi fa, il dolore mi ha chiuso in casa. Non ero in grado
di abbracciare i parenti, di raccogliere i mi dispiace tanto. Al funerale fissavo
impietrita la bara che veniva calata nelle labbra della terra scavata, i miei denti
serrati, i miei occhi spalancati.
E alla fine qualcuno è venuto a farmi i complimenti.
Leggevano il silenzio per mia madre come un virtuosismo professionale.
Avevano ragione.
Era il mio capolavoro artistico, e l'ho capito solo dopo, attraverso l'unico termometro di
cui un artista dispone: la reazione del suo pubblico.
E ora che ho la certezza di aver raggiunto il vertice so anche che le parabole sono per
loro natura discendenti. La mia non farà eccezione. Per questo vi sto scrivendo. Perché
riconosco finalmente, con l'intensità abbagliante di una nuova rivelazione, che la mia
riserva di silenzio si è prosciugata ed è venuto per me il momento di cominciare a
parlare.